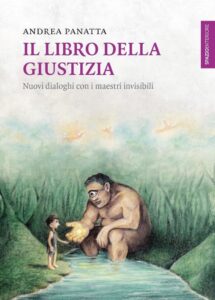Un breve viaggio nella Città Eterna, dove anche il suono dell’acqua che scorre diventa musica e arte
Parlare di acqua a Roma, nel pieno di un agosto siccitoso sembra solo un annoiato esercizio di stile, utile al rinfresco della memoria, rinchiusi al refrigerio artificiale di uno split casalingo. Ma l’esercizio rivela anche qualche sorpresa se ci si concentra a recuperare la memoria musicale di certe fontane, padrone incontrastate del silenzio che solo le notti agostane sanno regalare. E allora è divertente abbandonarsi a questo ozioso ripasso della memoria, per esplorare le risonanze artistiche che la materia liquida romana ha fornito nel tempo.

Fontana di Trevi a Roma
Dunque, abbiamo detto musica e cominciamo da quella che fa l’acqua che precipita nella tasca di caduta dei famosi nasoni distribuiti a genio per le strade cittadine. Oggi sono molto meno numerosi di quelli di una volta e molti dei sopravvissuti montano al lato un malinconico rubinetto, al servizio di un corretto comandamento di sobrietà, ma che ci priva, passeggiando di notte, di quella scorta musicale irripetibile che ti lascia ricordare che sei nel cuore della Città eterna, laddove perfino lo sperpero fastoso delle risorse idriche era il sigillo di unicità.
Ma Roma presenta tra le sue meraviglie più poetiche proprio le fontane, che sono tra le espressioni più vive del suo spirito. Da quelle monumentali -come la Fontana di Trevi– a quelle più intime, nascoste nei rioni, dove l’acqua scorre da secoli tra marmi antichi e leggende moderne.
A dare voce a queste pietre vive non è solo la luce: è anche la musica, come quella di Ottorino Respighi e il cinema, come in La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino (ovviamente, non dimentichiamo che anche molti altri artisti hanno celebrato Roma – come il menestrello romano per eccellenza, Antonello Venditti – o registi che hanno immortalato l’iconica Fontana di Trevi come Federico Fellini con la Dolce vita – chi non ricorda Anita Ekberg e Marcello Mastroianni a bagno nella Fontana – oppure Ettore Scola con il suo C’eravamo tanto amati).
Le fontane romane sono molto più che semplici decorazioni urbane: sono simboli di eternità. L’acqua, che da sempre rappresenta la vita, a Roma diventa anche spettacolo barocco e misticismo urbano. La Fontana dei Quattro Fiumi di Gian Lorenzo Bernini in Piazza Navona racconta l’intero mondo attraverso i suoi fiumi mitici; la Fontana dell’Acqua Paola, sull’omonimo colle Gianicolo, domina la città come un sipario che si apre su un palcoscenico senza fine. E proprio da qui, dalla Fontana dell’Acqua Paola, incomincia La Grande Bellezza. La macchina da presa scivola sul paesaggio romano mentre un coro di voci (I Lie, David Lang, Torino Vocalesemble) si sovrappone al rumore dell’acqua e si ha l’impressione che tutta Roma stia cantando la propria bellezza decadente.
Pochi hanno saputo trasformare Roma in musica come Ottorino Respighi, compositore del primo Novecento. Nella sua trilogia sinfonica dedicata alla città eterna – Fontane di Roma (1916), Pini di Roma (1924) e Feste Romane (1928) – è nelle Fontane che il suono diventa acqua, luce, atmosfera.
Respighi descrive quattro fontane in momenti diversi del giorno: La Fontana di Valle Giulia all’alba, dolce e meditativa; la Fontana del Tritone al mattino, piena di energia e vita; la Fontana di Trevi al meriggio, maestosa e drammatica e la Fontana di Villa Medici al tramonto, malinconica e sognante. È un’opera impressionista e narrativa insieme, in cui la città diventa paesaggio sonoro. Ascoltando Respighi, si ha l’impressione che ogni fontana parli, canti, respiri.
Nel film di Sorrentino, la Roma di oggi è vista con lo sguardo ironico e malinconico di Jep Gambardella, scrittore disilluso che si aggira tra feste decadenti, arte sacra e profana e una continua ricerca di senso. Roma è la vera protagonista del film: una città dove la bellezza è ovunque, ma è anche soffocante, come un sogno da cui non ci si sveglia mai. Il regista utilizza l’acqua e le diverse fontane riprodotte, come motivo visivo ricorrente, simbolo di un passato che ancora scorre, mentre tutto intorno pare essersi fermato. La musica, in questo, gioca un ruolo centrale: alterna canti sacri, brani elettronici e sinfonie evocative, come a voler unire il cielo e la terra, la spiritualità e la mondanità. La colonna sonora del film, curata dal musicista Lele Marchitelli, ha vinto diversi premi, ma non dimentichiamo l’Oscar per il miglior film straniero nel 2014.

Il nasone, la fontanella tipica di Roma
Le fontane di Roma, la musica di Respighi e il cinema di Sorrentino raccontano la stessa storia, ma in tre linguaggi diversi. Sono tre modi di fissare l’anima di una città che non smette mai di stupire. Roma è fatta di pietra e d’acqua, di suoni e silenzi, di luci e ombre. In ogni zampillo, in ogni nota, in ogni inquadratura c’è una domanda sulla bellezza e forse anche una risposta.
Per caso c’è qualcuno che vuole contestare perché non si è parlato di musica?
I film sopracitati:
“La Grande Bellezza” – Regia di Paolo Sorrentino – 2013
“La Dolce Vita” – Regia di Federico Fellini – 1960
“C’eravamo tanto amati” – Regia di Ettore Scola – 1974
Testi musicali:
I Lie, David Lang, Torino Vocalesemble
Colonna sonora del film “La Grande Bellezza”
“Fontane di Roma” (1916), “Pini di Roma” (1924) e “Feste Romane” (1928) di Ottorino Respighi