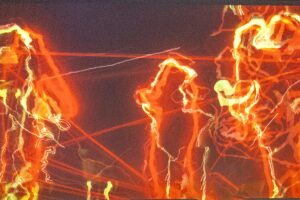Claudio Mancini, l’amico: «Sergio era un gran fijo de ‘na mignotta, praticamente un genio»
Seconda parte
Ipse dixit: «Basta western», ma un grande regista, un uomo che ha vissuto di cinema sin dalla nascita – il padre di Leone, Vincenzo, in arte Roberti Roberti, fu un pioniere del muto all’epoca di Francesca Bertini – è soprattutto, per indole artistica, un gran bugiardo. Non a caso Sergio Leone, che con i suoi film è diventato il maestro dell’antagonismo tra il Buono e il Cattivo, comincia le riprese di C’era una volta in America partendo proprio dalla lotta tra il Bene e il Male: un western in versione metaforica, una rappresentazione irreale tra le ombre di Rama e Ravana, personaggi antagonisti della mitologia induista. Affermare che, dopo la Trilogia del dollaro e i dopo «C’era un volta il west» e «Giù la testa», l’intenzione è di abbandonare il genere western suona come il campanello di un rito scaramantico: in questa storia di gangster la forza del Male sembra trionfare sul nascere, eppure sono l’Amore e l’Amicizia i sentimenti portanti del film. Fatto sta che quelle immagini, in perfetto stile giapponese, sono le prime a essere girate e tra le prime a essere utilizzate in fase di montaggio, come se Leone volesse far intendere che, anche lontano dai suoi pistoleri, le anime rivali del Far West restano vive ovunque. D’altronde i rapporti col Sol Levante dei samurai di Kurosawa si sono intrecciati, senza più lasciarsi, sin dai tempi di «Per un pugno di dollari» (1964).
A chi lo interroga sul nuovo progetto, Leone spiega molto chiaramente: «È il mondo dei gangster e della mafia ebraica attraverso l’occhio europeo.» Un’idea ben determinata, ma che poi sarà rimescolata con mille ripensamenti. «È un film sull’amicizia – dice ancora a Gianni Minà che lo intervista – un valore a cui io credo molto.» Poi affermerà pure che è un film sulla nostalgia. Un film sulla morte. Un film sulla memoria. Un film sul tradimento. Un film che ripercorre il Sogno americano. «C’era una volta in America» è certamente un’epopea che comprende tutto questo, ma la verità la rivela Enrico Medioli quando dice che è un film sul Tempo, con la lettera maiuscola.
Stabilite le epoche in cui si svolge la vicenda, infatti, viene fuori chiaramente che l’intreccio perlopiù farà parte di un racconto che lo spettatore vedrà in un lungo flashback, anzi due. Medioli ritrova nelle indicazioni di Leone quel senso del Tempo perduto che già da anni stuzzicava la fantasia di Luchino Visconti con il quale s’era più volte ipotizzata una sceneggiatura poi mai realizzata. Solo che qui «è la ricerca del tempo perduto di un gangster. Alla fine si scopre che è tutto un inganno – dice Medioli a Negri Scaglione – Quella battuta è mia, ed è un furto a Proust.» È l’incipit della Recherche.

«Che hai fatto in tutti questi anni?», chiede l’amico Fat Moe a Noodles, quando lo rivede all’improvviso nel 1968, dopo 35 anni. «Sono andato a letto presto.» Quello stesso interrogativo che oggi racconta tanto di madeleine quanto ormai di gangster, nel 2021, diventa il titolo della ricerca di Piero Negri Scaglione. Un libro affascinate che regala e svela agli amanti di C’era una volta in America un backstage storico lungo circa un ventennio, durante il quale il film è stato smontato e rimontato nella testa del suo autore un’infinità di volte; un’attenta esplorazione nel mondo onirico di uno «scrittore» che racconta per immagini: a tal proposito si sente la mancanza di un indice dei nomi, necessario per ritrovare primizie più gustose.
Il volume riporta la trascrizione di una registrazione audio, nella quale Leone descrive ai suoi sceneggiatori l’intera epopea, scena per scena; ma chi conosce il film sa bene che molti di quei particolari narrati non fanno parte né della pellicola, né della stesura finale della sceneggiatura. Ad ogni seduta si ricorda, per esempio, l’importanza della carrellata su un treno che trasporta automobili di varie epoche (è il tempo che passa), oppure una fondamentale sequenza girata in una sauna: due momenti che per anni sono state situazioni portanti del trattamento cinematografico, che hanno contribuito ad arricchire il film di particolari e farlo crescere (di tempo, di spese, di magnificenza) ma, prima l’una e poi l’altra, si sono dissolte in un attimo.
C’è addirittura – nel racconto del regista – un fiore colorato di rosso in un’inquadratura pensata in bianco e nero che, però, non fa parte delle riprese effettive di Leone, ma diventerà, anni dopo, la cifra di un altro caposaldo della cinematografia: Steven Spielberg riprenderà l’idea di una macchia colorata in campo grigio per il cappottino rosso della bambina in «Schindler’s list». Tutto, in fase di lavoro, cambia, perfino il produttore: Alberto Grimaldi si ritira per gli aumenti esorbitanti che si paventano; lui, ad ogni scena scritta, prende carta e penna e ricalcola i costi. Non ce la fa, dice con rammarico. Subentra Arnon Milchan, un ebreo con poca esperienza nel mondo del cinema, ma con grandi ambizioni. Leone spara una cifra poco più alta del previsto (22 milioni di dollari), Milchan accetta, anche se poi quel limite, che sembrava già eccessivo, verrà abbondantemente oltrepassato.
Si comincia a pensare al cast. De Niro è un punto fermo. Si scelgono i luoghi dei set: Stati Uniti, Canada, Italia. La maggior parte delle scene sarà girata a Cinecittà, ma molti saranno gli esterni. Il luogo simbolo è una zona di Brooklyn, chiamata Dumbo, che è un acronimo di Down Under the Manhattan Bridge Overpass (sotto il cavalcavia del ponte Manhattan). A Venezia si girerà la scena del ristorante. C’è una «sequenza di dodici minuti e mezzo iniziata a Montréal (l’uscita da teatro di Deborah, con Elizabeth McGovern), proseguita a Venezia (ristorante e spiaggia), poi in studio a Cinecittà (la violenza in macchina), per arrivare infine all’alba sulla costa del New Jersey: il giro del mondo» in meno di un quarto d’ora! Il bar di Fat Moe sarà ricostruito a Roma. Ed è lì che, Noodles al suo ritorno nel 1968, subito dopo la citazione proustiana, ritrova l’angusto sgabuzzino adibito a toilette, dove rimuovendo un listello di legno nella parete fa partire il flashback con Deborah bambina (Jennifer Connelly) che balla Amapola nel 1922. Lei vede lui che la spia, attraverso quel pertugio e anche lui torna ragazzino (Scott Tiler; vero nome, Scott Schutzman): in un attimo ciascuno rivede proiettato il proprio passato negli occhi dell’altro. È la magia del cinema. Lo stesso artificio lo sperimenterà, all’inverso, Giuseppe Tornatore in «Nuovo cinema Paradiso», quando il piccolo Salvatore si volta all’indietro a guardare nella bocca del leone (proprio un leone: sarà un omaggio?) il fascio luminoso che giunge dalla cinepresa per stamparsi sullo schermo e, lì dentro, nelle fauci del felino, scoprirà, non il passato, ma il proprio avvenire.

«Allarghiamo – è il regista che racconta il film – e vediamo la serratura di un deposito alla stazione dei treni o della metropolitana. Dalla cassetta vien fuori una valigetta da due lire. Lui la apre, e dentro ci sono solo fogli di carta.» La valigia diventa il perno della storia, appare tre volte: questa, appena letta, è la prima (1933); poi appare una seconda (1922) quando i ragazzi la usano come cassaforte ed è piena di soldi; e infine nel 1968 è ancora colma di denari. Qualcuno ce li ha rimessi. Allora il film diventa un giallo. All’interno della stessa anche un messaggio: «In pagamento per il tuo prossimo contratto.» È il mistero che regnerà per circa 200 minuti. L’altro grande mistero riguarda la figura che al finale scomparirà dietro il passaggio del camion della spazzatura: è il senatore, oppure no? E sarà davvero risucchiato nel tritarifiuti? La risposta migliore la rubiamo a Claudio Mancini che da fraterno amico di Leone dice: «Era un gran fijo de ‘na mignotta, praticamente un genio.»
Nella parte finale del libro si capisce quanta soddisfazione Sergio Leone ha ricevuto dal lavoro dedicato a questa pellicola, che è quella della vita, tanto che, se fosse stato possibile, l’avrebbe portata avanti per sempre: «C’era una volta in America sono io», disse il gran bugiardo in un attimo di sincerità. Purtroppo si intuisce anche quanta amarezza e quanto dolore gli procurò la decisione dei distributori americani di presentarla al pubblico in edizione ridotta e rimontata in sequenza cronologica. Un autentico delitto che portò l’autore a disconoscere quel figlio prediletto «fuggito» negli Stati Uniti: quindi non fu presentato agli Oscar. Così Milchan: «Non mi sono battuto abbastanza per salvare la versione completa.» Il 18 maggio 2012, ventitré anni dopo la morte del regista, il film è tornato a risplendere così come l’aveva pensato il gran bugiardo in un doppio dvd che è la testimonianza del genio di Sergio Leone.
Fine

____________________
C’era una volta in America, un film di Sergio Leone (1984). Per la scheda del film: https://it.wikipedia.org/wiki/C%27era_una_volta_in_America
Che hai fatto in tutti questi anni, volume di Piero Negri Scaglione (Einaudi, 2021)
Foto di copertina: Le riprese della morte di Dominic. «C’era una volta in America» di Sergio Leone Tutte le fotografie di scena e sul set sono di © Angelo Novi