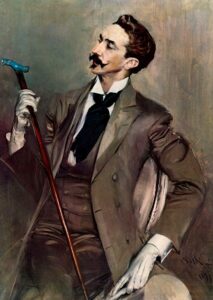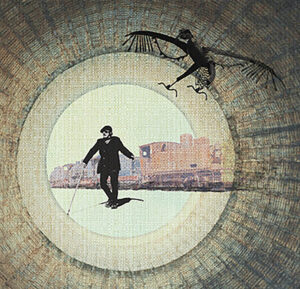Il Teatro Bellini di Napoli ritorna a un grande classico del teatro, Beckett: dal 13 al 29 novembre, va in scena Finale di partita, con la regia di Gabriele Russo.
Il gioco degli scacchi si divide in tre grandi momenti: l’apertura, il mediogioco e la partita finale. In realtà, non è detto che quest’ultima fase sia necessaria per decretare il vincitore, nel senso che ci si arriva se i due giocatori dimostrano di essere così abili da protrarre a lungo il gioco fino all’esigenza di una resa decisiva. Ad ogni modo, quando avviene che la partita non è decisa ancora fino alla fine, la scacchiera si caratterizza di un numero esiguo di pezzi rimasti e, in particolare, dal fatto che il re non è più soltanto il pezzo da difendere bensì diventa anche attaccante. Tenendo presente tale schema, ma inserendovi relazioni familiari nonché umane, Samuel Beckett finisce di scrivere Finale di partita nel 1956 – la prima rappresentazione si ha l’anno successivo al Royal Court Theatre di Londra con la regia di Roger Blin.

Nagg (Alessio Piazza) e Nell (Anna Rita Vitolo)
Quello di Beckett è un gioco dell’assurdo, ovvero una logica drammaturgica per la quale i rapporti umani esplodono in un immobilismo scenico che si traduce nell’impossibilità di comunicare, di incontrarsi, di vivere. Non a caso, le interpretazioni storiche del testo lo hanno ricollocato nello scenario dei residui traumatici ed effettivi sia della Seconda Guerra Mondiale sia dei campi di sterminio. Il regista Gabriele Russo, invece, nella sua interpretazione di Finale di partita in scena al Teatro Bellini, compie un’operazione di riduzione: riporta la drammaturgia al nucleo della famiglia, intimo e circoscritto dalle mura di un appartamento malandato. Allora, quel gioco di scacchi umani assume senso inserito all’interno delle dinamiche di una famiglia che è rifugio, come luogo protettivo per l’assurda incapacità di avere a che fare con l’esterno, e allo stesso tempo prigione, come spazio di immobilità soffocante, di assurdo vivere senza un’autentica e reale vita. L’assurdità del gioco beckettiano, appunto, si ritrova in quella quotidianità familiare di assenze, di dis-incontri, nel non riuscire più a distinguere vittime e carnefici. E se per l’autore era automatico pensare agli orrori lasciati dalla guerra, per noi è così difficile rievocare quel senso di essere intrappolati lasciatoci dalla pandemia?
Eppure, in quest’incapacità di abbracciare la vita c’è una percezione struggente di appartenenza a essa, un senso di aggrapparvi terribilmente umano. Perciò, nel suo Finale di partita, Gabriele Russo utilizza la prospettiva della famiglia: insieme alla scenografia di Roberto Crea adotta una visione rettangolare, come se fosse uno schermo che consente sia una visione d’insieme e sia la possibilità di ricreare una sorta di zoom su uno spazio intimo e abissale. È una lente d’ingrandimento sulla voragine delle relazioni, di un’umanità che privata di ogni ipocrisia rende visibile il vuoto, il baratro. Merita ulteriore menzione la distribuzione scenica sul palco perché, essendo divisa nettamente dalla platea, consente anche di rimarcare la distanza, l’assenza tragica e distruttiva di possibilità di contatto. E in questa cornice di condivisione del medesimo spazio, di forzato incontro, i personaggi si guardano senza guardarsi, si parlano senza parlare, ripetono gesti monotoni e progressivamente schizzano come schegge impazzite, ultimo baluardo di resistenza di un sentore di morte che li circonda. Assurdo, no? Ma, appunto, vero e tragicamente umano. Pertanto, le interpretazioni degli attori (Michele Di Mauro, Giuseppe Sartori, Alessio Piazza e Anna Rita Vitolo) non sono seguibili nell’immediato, c’è sempre una percezione di “arrivarci”: sono sussurrate, poi esplosive, si ritorcono su sé stesse, tentano di raggiungere. Ma, soprattutto, sembra sempre che attendino qualcosa ed è in questa spaccatura che si rivelano profondamente.
L’immobilismo è una caratteristica interessante nella rilettura moderna di Finale di partita. Al netto di un panorama teatrale come quello attuale in cui sembra sempre che ci si debba servire di particolari effetti e stratagemmi per ipnotizzare la platea, Gabriele Russo prorompe con la messinscena della sua rielaborazione del classico beckettiano. E lo fa realizzando una pièce che si prende i suoi tempi, si dilata fino in fondo per sviscerare quel coacervo di umanità autentica. Non c’è astrattismo, non c’è alcun intento di celebrazione dell’immenso drammaturgo Beckett, non ne ha bisogno. Anzi, c’è la volontà di guardarlo con gli occhi curiosi di chi interroga un classico che perpetra nel tempo la sua immensa energia, nonché la sua capacità attualizzante. È un’operazione che non necessita di ostentazioni, bensì di un pensiero che lo rilegga alla luce della contemporaneità. Per il regista, il codice di lettura è la famiglia, intesa come materialità dei rapporti, ciò che toglie astrusi e concettualizzazioni sull’assurdo rivelandone, al contrario, la terribile concretezza: «Nel 2025, dentro un mondo che sembra aver superato il proprio apice di senso, torno a Finale di partita partendo da lì: dalla famiglia come ultimo rifugio e, insieme, ultima prigione. L’intento è quello di liberare Beckett dalla cornice dell’Assurdo e del “dopo la fine del mondo” per restituirlo a una realtà che ci appartiene. L’assurdo non è un genere: è una condizione quotidiana. Vive nella ripetizione dei gesti, nelle abitudini che ci tengono in vita, nella paura di cambiare posizione, di uscire, di restare soli» – commenta Russo.
È sempre un’operazione non facile riportare un classico a teatro. Come farlo? Sarà noioso? Sarà troppo pesante? Cosa raccontare di quel testo ai giorni nostri? – sono solo alcune delle domande che inevitabilmente affollano la mente al netto della decisione di riscoprire e ridare parola a una drammaturgia appartenente a un tempo anteriore rispetto al nostro. È vero che un classico si definisce tale quando ha già insita quella straordinaria capacità di abbattere i limiti di tempo e di luogo, ma la questione complessa sta nel renderlo fruibile, accessibile nel presente. Allora, cosa rende in qualche modo riuscito un lavoro come Finale di partita di Gabriele Russo, ovvero vincente nell’avere catturato l’attenzione e nell’avere suscitato delle sensazioni?

Clov (Giuseppe Sartori)
Sicuramente il conferire alla messinscena un carattere in divenire: il regista stesso dichiara che lo spettacolo non nasce da un’idea già impostata e precisa, ma durante il lungo percorso delle prove ha esplorato le molteplici possibilità del testo di partenza. Questo comporta un continuo chiedere, un interrogarsi che porta a esplorare i sentieri che si aprono davanti. Ma non è un tentare allo sbaraglio, perché di sottofondo c’è un pensiero, un filo sottile che scioglie piano piano la matassa iniziale. In questo caso, il pensiero conduttore è l’obiettivo di non beckettizzare Beckett, di restituirgli contemporaneità attraverso una reale e cruda umanità senza le concettualizzazioni, senza le teorie dell’assurdo, che possono servire per i fruitori appassionati ma poco sulla scena. Ed è utile anche perché apre la scena ad altri futuri possibili. Questo, infine, significa chiedersi: a chi rivolgersi?
__________________
Finale di partita di Samuel Beckett – traduzione Carlo Fruttero – regia Gabriele Russo – con Michele Di Mauro – Hamm – Giuseppe Sartori – Clov – Alessio Piazza – Nagg – Anna Rita Vitolo – Nell – scene Roberto Crea – costumi Enzo Pirozzi – disegno luci Roberto Crea e Giuseppe Di Lorenzo – musiche e progetto sonoro Antonio della Ragione – Teatro Bellini di Napoli – dal 13 al 29 novembre 2025
Fonte immagini: Ufficio Stampa – ph. ©Flavia Tartaglia