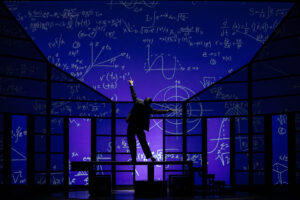Un viaggio emozionale tra templi antichi, gatti, storie nascoste e trasformazioni urbane: quando la città si racconta senza effetti speciali.
C’è un punto esatto in cui la storia ti si svela senza artifici, senza proiezioni o effetti speciali. Basta alzare lo sguardo o meglio abbassarlo e lasciarsi guidare dalla voce giusta. È quello che accade affacciandosi dalla terrazza del Teatro Argentina, nel cuore di Roma, davanti a una delle aree archeologiche più antiche e affascinanti della città: Largo di Torre Argentina.
Lì sotto, tra i resti di palazzi demoliti e strade ridisegnate, emergono quattro templi romani, identificati con le lettere A, B, C e D. Ma dietro quelle lettere c’è molto di più. Si tratta, infatti, di antichi santuari dedicati a divinità femminili legate all’acqua, elemento che in questa zona della città scorreva abbondante. E l’acqua, lo sappiamo, ha spesso un volto femminile: madre, nutrice, sorgente vitale. Alcuni studiosi parlano addirittura di sette templi, disposti in un fazzoletto di terra che conserva ancora oggi il respiro della Roma repubblicana.
Da lassù, la vista è mozzafiato. Ma non è solo questione di paesaggio. Il tempo si piega, il presente si ritrae, e tutto ciò che si muove intorno prende la forma di un racconto: quello della dottoressa Vanessa Ascenzi, funzionario della Sovrintendenza Capitolina, che con passione e rigore ha restituito ai presenti la voce della città sepolta, narrando la trasformazione urbanistica di Roma dopo l’Unità d’Italia.
Alla fine dell’Ottocento, Roma divenuta capitale ha fretta di mostrarsi moderna, efficiente, degna del suo nuovo ruolo. Inizia così una stagione di cantieri, di demolizioni, di aperture stradali. I quartieri vengono riscritti, le vie allargate per accogliere le automobili e il traffico in espansione. Via Vittorio Emanuele II nasce così, come asse monumentale che collega piazza del Gesù a Castel Sant’Angelo, tagliando nel vivo la città antica. Un’operazione radicale, spesso dolorosa, che però restituisce una Roma diversa, stratificata, dove il passato si lascia intravedere tra le pieghe del nuovo.
Intorno a Torre Argentina, però, il cambiamento è stato più graduale. La zona era un mosaico di stradine, botteghe, chiese e abitazioni. Una di queste vie, ancora oggi presente, si chiama via delle Botteghe Oscure. Il nome deriva proprio dal fatto che, in epoca medievale e moderna, era stretta buia, piena di piccole botteghe artigiane semi-interrate e spesso illuminate solo dalla luce delle lanterne. Era un dedalo pulsante di vita minuta e popolare, poi progressivamente trasformato, ma mai del tutto cancellato, dai grandi lavori tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento.
E il nome Torre Argentina? Nulla a che vedere con il Sud America, come si potrebbe immaginare. L’origine risale al XV secolo, quando Johann Burckardt, vescovo tedesco proveniente da Strasburgo (in latino Argentoratum), costruì una torre presso la sua residenza romana proprio in questa zona. La torre prese il nome di Torre Argentina, da cui derivò in seguito il nome dell’intera area. Un piccolo segno di quanto le identità di Roma siano sempre state il frutto di incroci, passaggi e stratificazioni.
Stare sulla terrazza del Teatro Argentina e ascoltare queste vicende significa fare un salto nel tempo, ma non come turisti distratti: è un atto di immersione, quasi di riconoscimento. Perché noi siamo fatti di storia e di storie, e ogni pietra racconta ciò che siamo stati e ciò che ancora siamo.
E c’è un altro elemento che rende questi percorsi ancora più significativi: la presenza della traduzione simultanea in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Un dettaglio solo in apparenza tecnico, ma che è in realtà un grande gesto di apertura. L’incontro infatti prevede la traduzione LIS grazie alla collaborazione tra la Sovrintendenza Capitolina, il Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e la Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio. Un segno concreto di inclusione culturale, che permette davvero a tutti di partecipare alla narrazione della città.
E poi ci sono i gatti, silenziosi custodi dell’area sacra, diventati parte del paesaggio, come se anche loro appartenessero a quel tempo antico. Un aneddoto tenero e romano ci ricorda che Anna Magnani, attrice simbolo della città, al mattino dopo colazione scendeva spesso a portare da mangiare ai gatti residenti nell’area archeologica. Una gattara autentica, come tante donne di Roma, capaci di prendersi cura della vita che scorre anche tra le rovine.
Alla fine della visita, si resta sospesi. Il rumore della città è lontano, la mente piena di immagini e la pelle attraversata da un’emozione sottile, antica. Roma continua a essere un cantiere vivo, in movimento. Ma è proprio questo il suo segreto: non smette mai di raccontarsi, a chi ha orecchie per ascoltarla.
_______________________
Terrazza del museo Teatro Argentina – Gli appuntamenti della sovrintendenza capitolina ai beni culturali, dal 25 al 31 luglio 2025 – guidati da Vanessa Ascenzi